
(Francesco Levoni) – La Libia del 2025 resta un sistema politico a bassa istituzionalizzazione, definito dal dualismo tra ovest ed est, dalla centralità delle milizie nelle aree urbane e da un’economia iper-dipendente dal petrolio. La crisi di governance continua a irrigidirsi in assetti “parastatali”, mentre attori esterni—dalla Russia alla Turchia, passando per Egitto, Emirati, Cina—proiettano influenza su nodi energetici, logistici e di sicurezza. Sullo sfondo, il dossier migratorio grava sui rapporti con l’Unione Europea e in particolare con l’Italia, oscillanti fra cooperazione energetica e pressioni sui diritti umani. A tenere insieme il quadro è la resilienza delle infrastrutture petrolifere, ma ogni shock politico-militare può trasformarsi in interruzione produttiva con effetti macroeconomici immediati.
Architettura del potere: Tripoli, Bengasi e la frattura del Sud
A Tripoli, il Government of National Unity (GNU) guidato da Abdulhamid Dbeibah conserva il riconoscimento internazionale, ma non il monopolio della forza: il controllo dell’ordine pubblico dipende da un equilibrio precario fra gruppi armati integrati solo nominalmente nello Stato. Le violenze del 12 maggio 2025, scatenate dall’uccisione del capo della Stability Support Apparatus (SSA), Abdel Ghani “Gheniwa” al-Kikli, e il conseguente confronto con la 444ª Brigata, hanno chiuso l’aeroporto di Mitiga e incrinato la fiducia nelle istituzioni, a partire dal Banco Centrale. Le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto indagini e responsabilità sui leader delle milizie. Questo episodio cristallizza la natura “segmentata” della sicurezza urbana tripolina.
In Cirenaica, l’asse HoR–LNA—Parlamento di Tobruk e forze del generale Khalifa Haftar—mantiene un controllo territoriale più coeso, con capacità coercitive e filiere di comando relativamente più stabili rispetto all’ovest. L’influenza orientale si estende nel Fezzan, fascia meridionale strategica per rotte di contrabbando e migrazione e per la profondità strategica verso Ciad, Niger e Sudan. Proprio nel Sud e nell’Est si è fatta più strutturata la presenza russa—oggi sotto l’etichetta Africa Corps—che ha investito in nodi logistici e basi, tra cui l’area di Maaten al-Sarra, con effetti a cavallo del Sahel. La dimensione militare esterna è ormai parte integrante dell’equilibrio interno libico.
Processo politico e quadro ONU: il “libyan-led” alla prova
Dal gennaio 2025 la Rappresentante Speciale Hanna Tetteh guida UNSMIL. Il 21 agosto 2025 ha presentato al Consiglio di Sicurezza una roadmap in tre pilastri: cornice elettorale tecnicamente solida e politicamente praticabile per presidenziali e legislative, unificazione delle istituzioni tramite un governo unitario e misure di fiducia per consolidare la tregua. Sul piano locale, nel 2025 si sono tenute elezioni municipali in 34 comuni (con alcune sospensioni), ma sul livello nazionale permane l’assenza di una base legale condivisa: senza accordo su legge elettorale e assetti di governo, le elezioni restano senza data. La canalizzazione del conflitto in un percorso istituzionale credibile è dunque incompleta.
Sicurezza e migrazioni: tregua fragile, Mediterraneo ad alta mortalità
Il cessate il fuoco del 2020 regge formalmente ma è vulnerabile a mobilitazioni improvvise e a competizioni per rendite territoriali. La frattura Tripoli/Bengasi produce “governance a macchia”, con focolai di violenza a intermittenza e un tessuto economico privato esposto a interruzioni logistiche. Nel frattempo, la costa libica rimane un hub della rotta del Mediterraneo centrale: nelle ultime settimane di settembre 2025, naufragi a Kambout e al largo di Tobruk hanno causato decine di vittime e decine di dispersi, in larga parte rifugiati sudanesi in fuga dal conflitto. Il mare a est di Derna resta uno dei tratti più letali per i movimenti irregolari verso l’UE.
Guardando ai flussi, l’OIM stima che oltre otto migranti su dieci (84%) in Libia provengano dai paesi confinanti o prossimi—Sudan (33%), Niger (22%), Egitto (19%), Ciad (10%)—a conferma della saldatura tra dinamiche libiche e crisi del Sahel e del Sudan. Nel 2025 migliaia di persone sono state intercettate e riportate in Libia, mentre il numero di morti e dispersi resta elevato. La dimensione regionale dei flussi rende inefficaci soluzioni esclusivamente costiere.
Economia politica degli idrocarburi: crescita a rischio-stop e finanza duale
Sul versante macro, l’IMF certifica per il 2024 un rallentamento della crescita reale del PIL a circa 2% (dal 10% del 2023), legato alla contrazione del settore idrocarburi e a shock interni; per il 2025 si attende un rimbalzo robusto, trainato dal recupero della produzione petrolifera, con un profilo di crescita più dinamico anche nel non-oil (+5–6% su orizzonte di medio termine). Si tratta però di un ciclo esposto a interruzioni, in assenza di riforme sulla spesa e di unificazione del quadro fiscale-finanziario.
La National Oil Corporation (NOC) ha riportato livelli di output attorno a 1,4 milioni di barili/giorno e ambizioni a 1,6 milioni nel breve e 2 milioni nel medio periodo. Nel luglio 2025 BP e Shell hanno firmato con NOC accordi per studi di potenziale su tre giacimenti, segnali di ritorno delle IOC insieme a operatori già radicati come Eni. Ogni strategia di rilancio, però, resta vulnerabile a blocchi portuali, dispute di rendita e minacce alle infrastrutture.
La dimensione monetaria e fiscale aggiunge fragilità: ad aprile 2025 la Banca Centrale ha svalutato il dinaro del 13,3%, fissando il nuovo tasso ufficiale a 5,5677 LYD/USD—decisione volta a correggere squilibri esterni, ma che sconta una doppia circolazione con tassi paralleli più deboli sul mercato informale. La frammentazione istituzionale—con apparati finanziari e di spesa duplicati tra est e ovest—spinge il disavanzo e alimenta pressioni inflattive, che le statistiche ufficiali faticano a cogliere appieno per via di sussidi e coverage geografico limitato del paniere. La finanza pubblica rimane il tallone d’Achille della stabilità.
Geopolitica: tra Mediterraneo orientale e Sahel, la partita delle potenze medie
Il dossier libico è ormai tessuto nella competizione per l’ordine del Mediterraneo allargato. Mosca, dopo la fase Wagner, opera con l’Africa Corps su assi logistici nel Sud e nell’Est, accreditandosi quale fornitore di sicurezza per l’LNA e proiettando influenza nel Sahel. Ankara, garante del campo tripolino in virtù degli accordi del 2019 (difesa e delimitazione marittima), ha intensificato attività navali congiunte e, più recentemente, approcci in Cirenaica, nella logica di una penetrazione trasversale che le consenta di negoziare con entrambi i poli. La riattivazione di contatti e visite navali a Tripoli e Bengasi nel 2025 segnala questa ambizione bilaterale.
Egitto e EAU mantengono il baricentro sul fronte orientale con supporto politico-militare a Haftar, allineando il dossier libico con le loro priorità di sicurezza di confine e contenimento delle reti islamiste. La Cina si muove a bassa visibilità: diplomazia economica, cantieristica, energia, con basso profilo militare ma disponibilità a rientrare su progetti di ricostruzione. L’UE e l’Italia, pur centrali su energia e migrazioni, subiscono gli effetti reputazionali di accordi-ponte con entità libiche coinvolte in abusi documentati contro migranti; il capitale politico europeo risulta quindi eroso, specie quando la cooperazione non si accompagna a verifiche indipendenti e accountability. La convergenza tattica tra potenze esterne resta possibile, ma l’agenda di lungo periodo è competitiva.
Mediterraneo, energia e rischio sistemico: la posta in gioco per l’Europa
Per l’Italia e per l’UE, la Libia rimane insieme fornitore energetico e cuscinetto migratorio. La coesistenza di questi dossier implica politiche talvolta divergenti: dove la sicurezza energetica spinge a investire—anche con Eni nei progetti gas e upstream—la tutela dei diritti e la gestione delle rotte irregolari impongono condizionalità difficili da far rispettare a istituzioni incompiute e a milizie con potere negoziale sul terreno. Il rischio è che la logica dell’emergenza prevalga su quella della riforma istituzionale, sterilizzando gli effetti positivi degli investimenti.
Scenari: continuità del dualismo, shock locali e “riforme sotto vincolo”
Nel breve-medio termine, tre vettori paiono determinanti. Primo: la persistenza del dualismo politico-militare. Senza una base legale condivisa e un esecutivo unificato, le elezioni nazionali resteranno lontane, con il rischio di consolidare una “federalizzazione di fatto” governata da patroni esterni e da economie di rendita locali. Secondo: la vulnerabilità a shock locali—omicidi selettivi, arresti di capi milizia, dispute su siti petroliferi o terminal—che possono interrompere produzione e traffico mercantile, erodendo gettito e divisa. Terzo: la traiettoria di “riforme sotto vincolo”—valutarie, fiscali, di governance NOC—che il paese è chiamato a implementare per stabilizzare inflazione e bilancia dei pagamenti, ma che scontano l’assenza di un bilancio unificato e di un centro di spesa credibile. La crescita del 2025 rischia dunque di essere congiunturale se non agganciata a istituzioni e catene del valore non-oil.
Una stabilizzazione “condizionata”
La Libia dispone di risorse energetiche e di una geografia strategica che potrebbero alimentare un ciclo di ricostruzione. Ma, nel 2025, la stabilizzazione resta condizionata: dall’unità delle istituzioni (politiche, militari, finanziarie), dalla sicurezza dei terminal e delle pipeline, da un accordo minimo tra Tripoli e Bengasi sul riparto delle rendite e sull’accesso alle valute, e da una gestione multilivello dei flussi migratori che guardi non solo alla costa, ma alla profondità saheliana dei movimenti. In assenza di questi prerequisiti, la traiettoria del paese continuerà a essere scritta—più che nelle capitali libiche—nelle cancellerie di Mosca, Ankara e Abu Dhabi, e nei mercati globali del greggio.






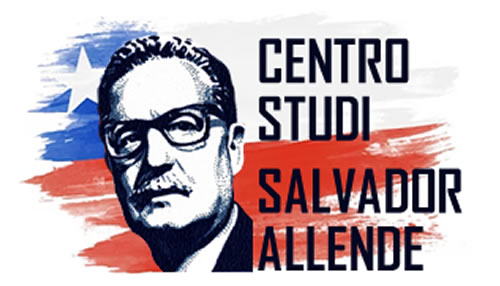






 e poi
e poi