
Le Forze di Supporto Rapido hanno espugnato il quartier generale della 6ª Divisione a El-Fasher e l’esercito sudanese si è ritirato dalle principali posizioni urbane. La conquista della capitale del Nord Darfur consegna ai paramilitari il controllo di fatto dell’intero Darfur e sposta gli equilibri di una guerra iniziata nell’aprile 2023: la presenza del SAF sembra ridursi a nuclei mobili ai margini della città, incapaci di reggere un fronte ormai spezzato. Sul terreno restano intrappolati circa 250–260 mila civili, metà bambini, da mesi esposti a bombardamenti e privati di rifornimenti regolari; l’assedio ha trasformato El-Fasher in un imbuto umanitario dove fame e paura dettano i tempi della sopravvivenza.
La dinamica militare è stata quella classica dell’accerchiamento lungo: settimane di combattimenti casa per casa, poi la penetrazione nel compound della 6ª Divisione e l’alzabandiera RSF. Testimonianze e immagini satellitari indicano danni estesi a infrastrutture civili e installazioni militari, mentre analisi indipendenti hanno rilevato la costruzione di oltre 31 chilometri di terrapieni per chiudere le vie di fuga, filtrare i movimenti e consolidare i varchi di ingresso; con l’avanzare delle linee sono aumentati i segni di incendi sistematici e nuove sepolture, un corollario ricorrente dei teatri d’assedio. In parallelo, l’Ufficio dell’Alto Commissario ONU per i diritti umani ha documentato uccisioni sommarie durante rastrellamenti casa per casa e attacchi, anche con droni, contro aree residenziali e strutture sanitarie: il Saudi Hospital, ultimo grande presidio del Nord Darfur, è finito più volte sotto pressione. A settembre i morti registrati in dieci giorni sono stati almeno 91, con nuove stragi segnalate a ottobre. Non è solo violenza indiscriminata: i pattern descritti richiamano motivazioni etniche, con comunità non arabe – Zaghawa, Berti e altre – particolarmente esposte; un’ombra lunga, se si considera che le RSF sono l’evoluzione delle milizie Janjaweed dei primi anni Duemila.
Il collasso dei servizi è l’altra faccia della caduta. UNICEF stima che circa 260.000 civili, tra cui 130.000 bambini, siano bloccati in città senza accesso regolare ad aiuti da oltre sedici mesi, mentre almeno 600.000 persone sono fuggite da El-Fasher e dai campi vicini. Le classificazioni IPC e gli allarmi FEWS NET segnalavano da tempo condizioni di fame/carestia (Fase 5) in parti dell’area, aggravate da blocchi stradali e interdizione degli aiuti. In assenza di corridoi sicuri e prevedibili, ogni tregua annunciata rischia di restare lettera morta: il cessate il fuoco di sette giorni accettato in estate dal SAF per far entrare i convogli non ha prodotto un miglioramento tangibile, e senza un impegno speculare delle RSF e meccanismi di monitoraggio sul campo la spirale umanitaria è destinata a peggiorare.
La rilevanza strategica va oltre il perimetro cittadino. Con El-Fasher, le RSF completano l’arco di controllo sulle cinque capitali statali del Darfur, saldano le linee logistiche verso ovest (Libia e Ciad) e consolidano una retrovia paramilitare che riduce la profondità operativa del SAF. In questo contesto, l’ipotesi di una spartizione di fatto tra est/nord controllati dall’esercito e ovest in mano paramilitare prende corpo anche sul piano politico: in luglio la coalizione guidata dalle RSF (Tasis/Sudan Founding Alliance) ha annunciato un’architettura di governance parallela con Hemedti alla guida di un consiglio presidenziale, tassello che – unito ai successi militari – avvicina lo scenario del “parastato”, irrigidisce i negoziati e stabilizza una linea di frattura territoriale e amministrativa. Il rischio più immediato, tuttavia, resta quello di nuove atrocità su base etnica, con arresti di massa, rastrellamenti e attacchi a ospedali e campi di sfollati già documentati in città e negli insediamenti di Abu Shouk e Zamzam.
Sul piano della responsabilità, la prima condanna della Corte penale internazionale per i crimini del Darfur – il caso Ali “Kushayb”, 27 capi d’accusa – dimostra che un percorso giudiziario è possibile e può avere un effetto deterrente; ma perché incida davvero sugli incentivi degli attori armati servono mandati aggiornati, cooperazione regionale e pressione coerente dei partner esterni. Il conflitto, nato dal braccio di ferro sulla riforma del settore di sicurezza dopo il colpo di Stato del 2021, ha militarizzato l’economia, frantumato le catene di approvvigionamento e attirato supporti esterni che le capitali coinvolte smentiscono o minimizzano. In questo quadro, qualsiasi intesa senza garanzie operative – protezione dei civili, accesso umanitario continuativo, monitoraggio indipendente – rischia di produrre solo una pausa tattica. La caduta di El-Fasher segna dunque un punto di non ritorno in Darfur: un guadagno territoriale per le RSF, un arretramento strategico per il SAF e, soprattutto, un salto di qualità nella vulnerabilità dei civili. Finché i corridoi non si apriranno davvero e la condotta delle forze non cambierà sotto il vincolo del diritto internazionale, la città resterà l’emblema di una guerra che si istituzionalizza e di una crisi umanitaria che non ha più margini di assorbimento.







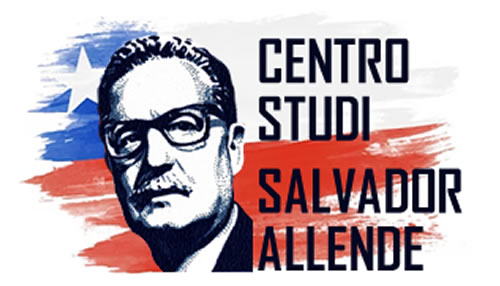






 e poi
e poi