
(Federica Cannas) – Il Cile entra nella campagna elettorale più densa degli ultimi decenni con la consapevolezza di trovarsi davvero a un passaggio decisivo della propria storia democratica. L’uscita di scena di Gabriel Boric, che non può ricandidarsi per il divieto costituzionale al secondo mandato consecutivo, apre un orizzonte nuovo non soltanto per il paese andino ma per l’intera America Latina, che guarda da anni al Cile come a un laboratorio politico in continuo movimento. La sensazione diffusa è che queste elezioni racchiudano una sfida più grande dell’alternanza, perché chiamano in causa l’eredità di un presidente giovane che ha provato a cambiare l’architettura sociale del paese e la direzione che il nuovo Cile vorrà imboccare.
La presidenza di Boric è stata la più audace della storia recente del Cile. L’arrivo alla Moneda di un leader poco più che trentacinquenne, proveniente dal movimento studentesco, aveva rotto l’immaginario tradizionale della politica nazionale e aperto la porta a una generazione che non aveva partecipato né alla stagione della dittatura né alle battaglie della transizione democratica. Questo elemento, spesso citato come causa delle difficoltà incontrate dal governo, ha invece rappresentato uno dei passaggi più significativi degli ultimi anni, perché ha imposto un ricambio reale nei centri decisionali e ha costretto l’intero sistema politico ad aggiornare linguaggi, priorità, sensibilità.
Nonostante un contesto internazionale sfavorevole, segnato dalla crisi economica globale, dall’inflazione e dalle tensioni sociali post pandemiche, Boric ha mantenuto ferma l’idea che la politica dovesse tornare a essere un luogo capace di ascoltare la vulnerabilità del paese. La sua amministrazione ha portato al centro della scena questioni da tempo rimosse, come la riforma delle pensioni, il rafforzamento dei diritti del lavoro, un nuovo rapporto con i giovani e una politica culturale più attenta ai territori. Il suo governo ha valorizzato figure femminili in ruoli chiave e aperto spazi istituzionali a chi non aveva mai avuto voce nel dibattito pubblico, portando avanti un’idea di politica più inclusiva rispetto alle stagioni precedenti.
Il progetto costituzionale, poi respinto dalla maggioranza dei cileni, è stato forse l’episodio più discusso degli anni di Boric. Tuttavia, al di là dell’esito referendario, l’intero processo ha permesso a settori della società civile di riscoprire un protagonismo che mancava da tempo e ha acceso una discussione collettiva sull’identità e sulle fragilità del paese, restituendo dignità a temi che per anni erano rimasti ai margini. La capacità del presidente di accettare democraticamente la sconfitta senza alimentare tensioni, mantenendo il paese in un clima di stabilità istituzionale, è stata una dimostrazione di maturità politica che anche molti avversari gli hanno riconosciuto.
Ora, con le elezioni del 2025, il Cile si ritrova a dover decidere quale eredità del governo Boric conservare e quale direzione imprimere alla prossima fase. Jeanette Jara, espressione della coalizione progressista che ha sostenuto l’azione dell’esecutivo uscente, propone un percorso di continuità realista, consapevole delle sfide ma determinato a riprendere il lavoro rimasto incompiuto. Dall’altra parte, José Antonio Kast interpreta l’ansia di una parte del paese che chiede un ritorno all’ordine, a un approccio più tradizionale in materia di sicurezza e a una linea economica più conservatrice. Evelyn Matthei incarna invece una via moderata, ancorata a una destra pragmatica che punta sulla gestione e sulla stabilità.
Il dibattito ruota attorno a grandi temi che attraversano l’intero continente. La sicurezza, che rimane una delle principali preoccupazioni dell’elettorato. L’economia, con l’esigenza di stabilizzare l’inflazione senza rinunciare alle politiche sociali. Le migrazioni, diventate una questione strutturale. Le disuguaglianze, ancora profonde e distribuite in modo irregolare tra centro e periferie. Ma dietro ogni singolo punto si intravede un interrogativo più profondo: che tipo di società vuole diventare il Cile dopo l’esperienza di Boric.
Il futuro della politica cilena dipenderà anche dalla capacità dei candidati di leggere la trasformazione culturale prodotta dal quadriennio appena trascorso, perché l’impatto della presidenza Boric non si esaurisce nel giudizio sui risultati, ma nell’avere modificato l’immaginario collettivo, introducendo nella conversazione pubblica temi che continueranno a influenzare il dibattito per molti anni. La sua sfida più grande non è stata quella di cambiare il paese da un giorno all’altro, ma di aprire un varco attraverso cui nuove generazioni politiche possano passare.
Le elezioni del 2025 arrivano dunque come una prova generale del futuro, un test che misurerà quanto il Cile sia disposto a proseguire su un cammino di riforma sociale e culturale o quanto preferisca cambiare rotta affidandosi a una visione più conservatrice. Qualunque sarà l’esito, rimane un dato: il paese che andrà alle urne è diverso da quello che, quattro anni fa, consegnò a Boric la responsabilità di guidarlo. E in questa trasformazione si trova la vera eredità del suo governo, un’eredità che continuerà a segnare il destino del Cile ben oltre il nome del prossimo presidente.






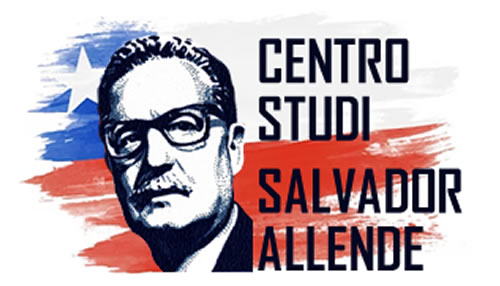






 e poi
e poi