
(Federica Cannas) – La miccia si è accesa lo scorso 5 ottobre, durante un’intervista televisiva su LN+. Il presidente argentino Javier Milei, incalzato su vari temi, ha pronunciato una frase che ha immediatamente fatto il giro del Paese: «Soy el primer presidente que tomó la decisión de que Cristina vaya presa», ovvero “Sono il primo presidente che ha preso la decisione di mandare in prigione Cristina Kirchner”.
Cristina Fernández de Kirchner, ex presidente e figura cardine del peronismo, condannata nel giugno scorso dalla Corte Suprema argentina a sei anni di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per la cosiddetta Causa Vialidad, è così tornata al centro della scena.
Alla replica del conduttore, che gli chiedeva se non fosse un’ingerenza diretta nella magistratura, Milei ha tentato di correggere il tiro: “Io non mi immischio nella giustizia… se avessi sistemato le cose per evitare che la mettessero in carcere, non starei soffrendo tutto questo”.
Due frasi, una dopo l’altra, che si annullano e si accusano reciprocamente. Per molti, sono la più chiara ammissione di lawfare mai uscita dalla bocca di un presidente in carica. Per altri, soltanto un’iperbole maldestra pronunciata con leggerezza.
L’avvocato Gregorio Dalbón, difensore di Cristina Kirchner, non ha lasciato passare la dichiarazione. Ha presentato una denuncia penale contro Milei per abuso di autorità e interferenza nel potere giudiziario, chiedendo anche che gli atti vengano trasmessi alla Camera dei Deputati per un eventuale procedimento di impeachment.
Dalbón sostiene che Milei, con le sue parole, ha confermato ciò che il kirchnerismo denuncia da anni. Ossia che la giustizia argentina è stata usata come arma politica per colpire un’avversaria scomoda. “Ha confessato — ha detto l’avvocato — che la persecuzione è stata politica, e che lui l’ha avallata.”
Il governo ha tentato di ridimensionare la portata dell’episodio, spiegando che il presidente si riferiva a una “decisione politica” in senso lato, non a un intervento diretto sui giudici. Ma la miccia era ormai accesa: le parole di Milei sono diventate il detonatore di un dibattito più profondo e antico, che attraversa l’Argentina da anni. Cristina Kirchner, due volte presidente e ancora oggi figura influente della politica argentina, è da tempo al centro di processi e accuse che i suoi sostenitori considerano parte di una strategia di lawfare, ovvero l’uso della giustizia come strumento di guerra politica.
Il caso Vialidad, relativo alla gestione di appalti pubblici durante i suoi governi, è arrivato in Corte Suprema, che il 10 giugno 2025 ha confermato la condanna a sei anni di prigione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dopo la sentenza, Kirchner ha chiesto gli arresti domiciliari per motivi di salute e sicurezza personale.
Da allora, la polarizzazione si è acuita. Da un lato, chi vede nella condanna una prova della forza delle istituzioni; dall’altro, chi la interpreta come l’ennesima tappa di una persecuzione politica. Le parole di Milei hanno agito come benzina su un fuoco già acceso.
Il caso argentino non è isolato. Il lawfare è diventato una parola chiave del dibattito politico latinoamericano. Un concetto che descrive la manipolazione giudiziaria a fini politici, usata per neutralizzare figure scomode attraverso la via legale.
È successo in Brasile con Lula da Silva, imprigionato nel 2018 e poi assolto; è accaduto in Ecuador con Rafael Correa; e torna oggi in Argentina con Cristina Kirchner.
La domanda di fondo è sempre la stessa. La giustizia può restare neutrale quando diventa il terreno su cui si combatte la lotta per il potere?
Nel caso di Milei, la gravità non sta solo nelle parole, ma nel fatto che provengano dal vertice dell’esecutivo, da colui che dovrebbe garantire la separazione dei poteri. Una frase come “ho deciso io che andasse in prigione” non è solo uno scivolone, mina la fiducia nelle istituzioni e legittima la convinzione che la politica possa piegare la giustizia ai propri fini.
L’Argentina, in questo senso, è uno specchio che riflette una tendenza globale. Anche in Italia, pur in un contesto istituzionale diverso, l’idea di una giustizia utilizzata come strumento politico è tornata più volte al centro del dibattito pubblico.
Negli anni Novanta, l’inchiesta Mani Pulite chiuse un’epoca politica, lasciando dietro di sé la sensazione che la magistratura potesse trasformarsi nel nuovo arbitro della vita pubblica.
Da allora, l’espressione “giustizia a orologeria” è entrata stabilmente nel linguaggio politico, riaffiorando ogni volta che un’inchiesta o un avviso di garanzia compaiono in momenti decisivi, durante una campagna elettorale, alla vigilia di un voto parlamentare, o nel pieno di una crisi di governo, alimentando il sospetto che la tempistica giudiziaria possa coincidere, non per caso, con quella del potere.
Ancora oggi, quando figure di governo vengono raggiunte da avvisi di garanzia, il sospetto di un uso politico della giustizia riemerge con forza. Non si tratta solo di difendere o accusare, ma di interrogarsi sul rapporto fragile e pericoloso tra potere, diritto e verità.
Le parole di Milei hanno riportato in primo piano una questione che non riguarda solo Buenos Aires. Ogni volta che un leader politico parla come se la giustizia fosse una sua estensione, la democrazia vacilla.
Cristina Kirchner, con il suo lungo percorso politico e giudiziario, è oggi il volto più visibile di una battaglia che non riguarda solo lei, ma la tenuta dello Stato di diritto.
La vera domanda, oggi come ieri, resta aperta. Chi decide davvero in una democrazia?
E forse, questa volta, l’Argentina non è così lontana da noi.






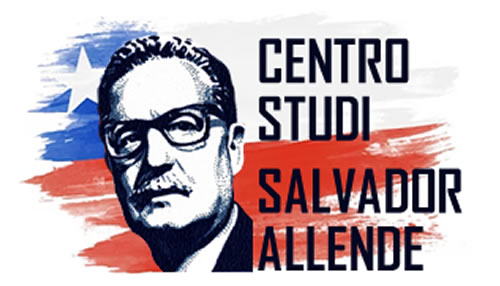






 e poi
e poi