
(Federica Cannas) – La COP30 si chiude con un documento incapace di nominare ciò che la scienza ripete da anni. Il motore del disastro climatico sono i combustibili fossili. È un’omissione pesante, resa ancora più paradossale dal fatto che questa conferenza si sia svolta nel cuore dell’Amazzonia, una delle regioni più vulnerabili del pianeta e simbolo stesso di ciò che il cambiamento climatico minaccia.
Il testo finale non include né un impegno vincolante sulla fine di petrolio, carbone e gas né un calendario per l’eliminazione progressiva. È una scelta politica precisa, non un incidente negoziale. E proprio su questa scelta si è consumata la frattura più significativa della COP. La Colombia si è opposta apertamente all’accordo.
Il presidente colombiano ha spiegato pubblicamente la ragione del rifiuto. Accettare un accordo che non nomina la radice del problema significherebbe, a suo giudizio, tradire la scienza e svuotare di senso il processo multilaterale.
Le sue parole sono chiare. La crisi climatica nasce dal carbone, dal petrolio, dal gas. Ogni tonnellata di CO₂ prodotta da queste fonti accelera il collasso climatico. Una conferenza che evita questo nodo non solo è inefficace, ma rischia di diventare un rituale senza conseguenze.
È una posizione netta e coerente con la traiettoria assunta dalla Colombia negli ultimi due anni: un ambientalismo che non separa la transizione ecologica dalla giustizia sociale e dalla critica al modello estrattivista dominante.
La scelta colombiana non è stata accolta con entusiasmo. Al contrario, si è tradotta in un isolamento diplomatico significativo.
L’Unione Europea e l’Unione Africana hanno sostenuto il testo finale, mentre i paesi produttori di petrolio, dal Golfo al Venezuela, hanno esercitato una pressione evidente per evitare qualsiasi riferimento alla fase-out dei fossili.
La Colombia, invece, ha difeso una posizione che oggi è più popolare tra gli scienziati che tra i governi: la transizione dal capitale fossile a un’economia verde non è un auspicio, è una necessità. E riguarda anche i paesi che vivono di petrolio, perché l’oro nero non garantisce stabilità ma conflitti, competizione, vulnerabilità.
La fragilità dell’accordo è il sintomo di una crisi più ampia. Le COP rischiano di trasformarsi in grandi palcoscenici che producono documenti privi di conseguenze. La distanza tra ciò che la scienza indica come non più rimandabile e ciò che la politica è disposta a firmare diventa ogni anno più evidente.
Lo scontro non è solo tecnico, ma geopolitico. Da un lato, i paesi che tentano di difendere i propri interessi fossili, dall’altro, chi chiede una rottura reale con il passato. Nel mezzo, un multilateralismo incapace di imporre decisioni difficili.
La COP30 non ha trovato il coraggio di cambiare questo scenario.
In questo contesto, il dissenso colombiano assume un valore politico che va oltre il suo peso specifico. Non è solo una critica a un documento. È l’affermazione che la difesa della vita e delle comunità amazzoniche, costiere, contadine, urbane viene prima degli equilibri diplomatici.
La sua è una posizione minoritaria sul piano negoziale, ma rappresenta una voce crescente nel Sud globale. Un Sud che non accetta più che la transizione sia ritardata per difendere un’economia fossile che sta portando il mondo verso il limite fisico del collasso.
La conferenza ha evitato la domanda decisiva: può il mondo sfuggire al collasso climatico, continuando a proteggere il cuore del capitalismo fossile?
La Colombia risponde di no.
La maggioranza dei governi ha preferito non rispondere.
Ed è proprio in questo silenzio che si misura la crisi della governance climatica. La COP30 avrebbe potuto essere una svolta. È stata un’occasione mancata. E il fatto che una voce sudamericana sia rimasta sola nel ricordarlo dice molto più dell’accordo finale.






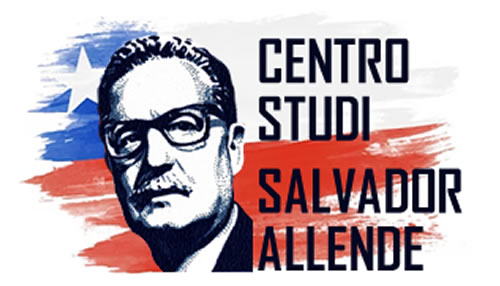






 e poi
e poi