
(Federica Cannas) – “¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?” Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel per la Pace nel 1980, rivolge questa frase a María Corina Machado, recentemente insignita dello stesso riconoscimento. Non è una provocazione, ma un atto di coscienza politica.
La sua lettera, pubblicata dal quotidiano cileno El Ciudadano con il titolo “De Nobel a Nobel”, è una chiamata alla responsabilità, un messaggio che supera il caso venezuelano e tocca il cuore del progetto latinoamericano di autonomia e dignità. Pérez Esquivel parla da testimone. Sopravvissuto alle dittature, alla tortura e all’arroganza dei regimi, conosce il peso delle parole quando si pronuncia la parola pace.
Per lui, il Nobel non è un premio personale ma un impegno con i popoli che lottano per la propria autodeterminazione. Ecco perché la richiesta di Machado agli Stati Uniti, di intervenire militarmente in Venezuela per deporre il governo di Nicolás Maduro, gli appare come una frattura morale, prima ancora che politica. Chiede come possa, chi invoca la libertà del proprio Paese, sollecitare la forza di una potenza straniera. Dove finisce la resistenza e dove comincia la sottomissione?
La sua domanda è forte. “¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?”
Dietro, c’è la memoria lunga dell’America Latina. Guatemala, Cile, Panama, Grenada, Iraq, Libia. Ogni volta, l’intervento esterno è stato presentato come liberazione, ma si è trasformato in dominio.
Esquivel risponde con la lucidità del ricordo. Sa che l’uso del linguaggio è il primo passo verso la legittimazione della violenza. Ecco perché si indigna quando Machado dedica il suo riconoscimento al presidente statunitense Donald Trump, “l’aggressore del tuo Paese”, come la definisce nella lettera.
Quel gesto simbolico, apparentemente formale, diventa per lui la prova di un fraintendimento profondo: la confusione tra la libertà e la dipendenza.
Il richiamo di Esquivel è chiaro: chi detiene un titolo morale come il Nobel deve esserne all’altezza. La pace non è mai un atto di potere, ma di autonomia. Non si costruisce invocando eserciti stranieri, né si difende affidando il destino di un popolo alle strategie di Washington.
Nella sua lettera, Esquivel rievoca la memoria delle dittature del Cono Sud, le stesse che usarono la “sicurezza nazionale” come pretesto per reprimere ogni dissenso.
In quelle stagioni, l’appoggio statunitense non fu un dettaglio geopolitico ma una struttura di potere. Per questo, chiede a Machado di riconoscere la continuità di quel modello: cambiano le giustificazioni, ma non l’obiettivo.
Il blocco contro Cuba, l’embargo al Venezuela, le sanzioni come strumento politico: tutto ciò, dice Esquivel, rappresenta un attacco alla libertà dei popoli e una violazione sistematica del diritto internazionale.
La coerenza diventa, allora, il punto centrale della sua denuncia. Non basta proclamarsi democratica, se il metodo contraddice il fine. Non basta combattere l’autoritarismo, se si accetta l’idea di un’autorità straniera come risolutrice.
Per Esquivel, ogni richiesta di intervento esterno è una resa morale prima che politica.
Il premio Nobel argentino invita Machado a “sapere dove si trova”: “Analiza y sabe dónde estás parada”, scrive. Un ammonimento diretto, ma anche un appello all’introspezione. Le suggerisce di chiedersi se non sia diventata “una pedina del colonialismo statunitense”, prigioniera di interessi di dominazione più ampi di lei.
Il suo è un avvertimento universale. Ogni leader latinoamericano deve scegliere se stare dalla parte dei popoli o dei poteri. Chiude citando Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.” È un invito a costruire la pace passo dopo passo, svuotando “il recipiente della violenza” e riempiendolo di solidarietà e unità popolare.
L’intervento di Pérez Esquivel non è solo una presa di posizione sulla Venezuela, ma una riflessione sul destino politico del continente. L’America Latina, da oltre un secolo, vive in bilico tra autonomia e dipendenza. Le crisi interne diventano sempre l’occasione per giustificare nuove forme di ingerenza.
Il caso Machado mostra quanto sia fragile il confine tra il linguaggio della democrazia e quello dell’intervento “umanitario”.
Ogni volta che un leader invoca la forza straniera, riattiva una ferita storica che la regione non ha mai sanato.
Esquivel ricorda che non può esistere pace senza giustizia, né libertà senza sovranità. E che il Nobel, per chi lo riceve, non è un trofeo, ma una prova.
Una prova di coerenza, di rispetto della memoria, di lealtà verso chi ha lottato e sofferto per costruire la propria indipendenza.
Nella voce di Pérez Esquivel si riconosce il filo rosso che attraversa la storia politica del Sud del mondo: ’urgenza di una pace che non sia subordinazione, ma autodeterminazione.
La sua lettera, asciutta e diretta, cerca verità.
E in quella verità pone una domanda a tutti, non solo a Machado: che senso ha parlare di libertà, se la si costruisce con le armi di chi l’ha sempre negata?
L’America Latina, con le sue ferite e le sue resurrezioni, sa che la pace si conquista.
E Pérez Esquivel, con lsobrietà, ricorda che chiamare un esercito straniero significa tradire il primo principio della libertà: quello di essere padroni del proprio destino.






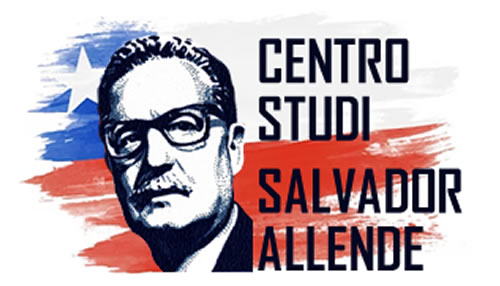






 e poi
e poi