
di Alessandro Aramu
Quando degli imputati entrano in aula e vengono accolti dagli applausi, nonostante l’accusa di stupro, e quegli imputati sono soldati dello Stato israeliano mentre la vittima è un palestinese detenuto, non siamo di fronte a una distorsione procedurale né a un semplice deragliamento del sistema giudiziario: siamo davanti a un rito collettivo che celebra la disumanizzazione. Gli applausi non sono un rumore di fondo, ma una dichiarazione identitaria: la violenza – anche quella sessuale, anche quella più degradante – può essere tollerata, perfino premiata, se esercitata da chi si considera “dalla parte giusta”.
In questo contesto, le denunce su Sde Teiman, le testimonianze che parlano di torture sistematiche, abusi sessuali, violenze aggravate e persino di stupri di gruppo, non scuotono la coscienza pubblica ma vengono inghiottite da una logica di appartenenza che sostituisce il criterio della dignità umana con quello del nemico (arabo, palestinese) disumanizzato.
L’applauso, dunque, assume un valore micidiale: diventa la ratifica pubblica dell’idea che l’abuso, se compiuto dal soldato contro il palestinese, non sia un crimine ma un surplus di lealtà, un’espressione del ruolo, un gesto inscrivibile nella narrazione del conflitto. La vittima, ridotta alla somma delle sue identità – prigioniero, arabo, palestinese – viene spogliata dei diritti minimi, della protezione contro la violenza, perfino della possibilità di essere riconosciuta come soggetto umano.
Gli applausi sono una sentenza parallela che dice tutto: quella sofferenza non conta, quel corpo non conta, quella testimonianza non deve interferire con il mito della purezza morale del soldato. È qui che entra in gioco la complicità del pubblico, quel frammento di società che non si limita a negare la gravità delle accuse, ma conferisce al gesto criminale una patina di legittimità. Perché se è vero che la violenza sessuale è uno dei crimini più universalmente condannati, è altrettanto vero che in certi contesti diventa improvvisamente negoziabile, normalizzata, resa compatibile con l’ideologia di appartenenza. E questo ribaltamento avviene non nelle stanze del potere, ma nei gesti collettivi, nei simboli, nei comportamenti che trasformano un processo per stupro in una passerella di sostegno emotivo agli accusati. Anche le istituzioni, consapevoli della gravità delle denunce su Sde Teiman e allo stesso tempo immerse in un sistema che fatica a riconoscere la pari umanità dei detenuti palestinesi, finiscono per lasciare che questo clima continui indisturbato.
Le indagini, gli scandali, perfino la vicenda della fuga di notizie attribuita all’ex procuratrice militare Yifat Tomer-Yerushalmi, diventano parte di una trama in cui la giustizia è percepita come minaccia all’equilibrio identitario più che come strumento di verità. Il risultato è una società che non si limita a tollerare la violenza, ma la integra nel proprio immaginario morale quando la vittima appartiene alla categoria dell’“altro”, quella in cui la dignità è sempre sospesa, la testimonianza sempre discutibile, il dolore sempre irrilevante.
In questo scenario, parlare di doppia morale è persino riduttivo: lo stupro, che dovrebbe essere un limite invalicabile, diventa invece un crimine valutato in base all’identità del corpo violato e non alla brutalità dell’atto. L’impunità culturale che ne deriva attribuisce ai soldati uno statuto quasi sacrale, un’immunità di fatto che trasforma la violenza contro il nemico in possibilità, se non in diritto. È un processo lento, ma devastante: la violenza sessuale si istituzionalizza non perché lo Stato la ordina, ma perché la società la giustifica, la addomestica, la assorbe come inevitabile e, infine, la applaude. A quel punto, anche la giustizia si svuota: il processo non è più il luogo della verità, ma l’arena in cui si difende uno status morale preesistente, e la semplice azione di portare alla sbarra un soldato accusato di stupro appare come un gesto quasi sovversivo.
La conclusione è brutale ma inevitabile: chi applaude quegli uomini non sta applaudendo delle persone, sta applaudendo un principio, quello secondo cui alcuni corpi possono essere violati senza conseguenze, e quell’idea – più del singolo crimine – è il vero abisso. Finché l’applauso continuerà a coprire la voce della vittima, finché il sostegno pubblico diventerà scudo simbolico per gli accusati, la società non potrà chiamarsi civile: sarà invece complice, attiva, responsabile della disumanizzazione che alimenta. E ogni applauso, in questo contesto, è un atto morale in sé, un gesto che merita condanna quanto il crimine che difende.






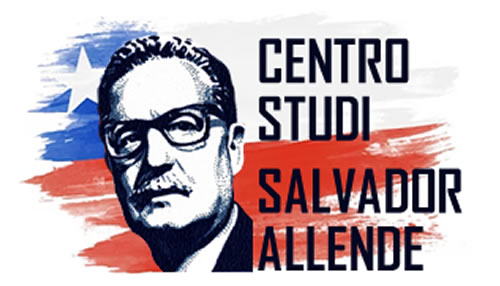






 e poi
e poi