
L’azione sempre più extraterritoriale di Israele e l’asprezza dello scontro politico con Doha stanno ridefinendo le geometrie del Golfo e, insieme, erodendo il pilastro diplomatico su cui si reggevano gli Accordi di Abramo: la promessa che normalizzazione e cooperazione economica potessero convivere — e attenuare — il conflitto israelo-palestinese. Gli sviluppi più recenti indicano che la linea di Benjamin Netanyahu, puntellata da un uso disinvolto della forza oltre confine, sta creando un nuovo ordine regionale centrato sulla coercizione e su intese tattiche variabili. Ma quel medesimo approccio corrode la legittimità e la sostenibilità politica delle normalizzazioni avviate dal 2020, incrinando il ruolo dei mediatori (Qatar in primis) e complicando l’obiettivo — perseguito dagli USA — di un allargamento a Riad.
Il “caso Qatar”: un limite superato
Il Qatar ospita Al Udeid, principale hub militare statunitense in Medio Oriente e sede del Combined Air Operations Center che governa le operazioni aeree di CENTCOM sull’intera regione; è dunque un alleato di lungo corso di Washington.
Dal 2023, Doha è anche mediatore cardine nei negoziati su cessate il fuoco e ostaggi a Gaza, in coordinamento con Egitto e Stati Uniti. In parallelo, però, lo scontro politico tra Israele e Qatar è montato: Tel Aviv accusa Doha di “ospitare” Hamas; Doha replica che quella presenza è strumentale alla mediazione e avviene in trasparenza con partner occidentali. Lo strappo è divenuto crisi aperta con il bombardamento israeliano su obiettivi di Hamas a Doha, che ha provocato vittime e un’ondata di condanne internazionali; fonti d’agenzia riportano frizioni anche fra Washington e Gerusalemme per la mancanza di coordinamento sull’operazione. Il governo qatariota ha definito l’attacco una violazione della propria sovranità e un sabotaggio alla mediazione. Qualunque sia l’evoluzione giudiziaria e politica dei fatti, l’episodio segna una nuova frontiera nella proiezione israeliana e colpisce al cuore l’architettura di mediazione costruita dal 2023.
Implicazione chiave: se Doha riduce o condiziona il proprio ruolo di facilitatore — eventualità già ventilata in passato — i canali negoziali su cessate il fuoco e scambi di prigionieri si assottigliano, aumentando il rischio di un conflitto “a inerzia” privo di valvole diplomatiche.
Il “nuovo ordine” secondo Netanyahu: deterrenza extraterritoriale e diplomazia punitiva
Le operazioni al di fuori dei teatri immediati (da Yemen all’Iran, fino al Qatar) compongono una dottrina di deterrenza espansiva che mira a colpire architetture logistiche e politiche di Hamas e degli attori allineati, segnalando che nessun santuario è intangibile. La scelta di agire persino su suolo di un alleato USA, con il quale sono in corso negoziati sensibili, indica che per Netanyahu la priorità tattica (neutralizzare leadership nemiche) prevale su costi reputazionali e diplomatici, confidando che l’asse con Washington regga l’urto. Le prime reazioni statunitensi e alleate suggeriscono però irritazione e timori di escalation incontrollata.
A questa postura di coercizione si è affiancata, dal 2024, una marcata guerra politico-informativa (chiusura di Al Jazeera in Israele e cornice legale per oscurare media stranieri ritenuti nocivi alla sicurezza), con l’effetto di irrigidire ulteriormente i rapporti con Doha — proprietaria dell’emittente — e con numerosi partner occidentali.
Gli Accordi di Abramo: resilienza economica, fragilità politica
Gli Accordi di Abramo, firmati nel 2020, avevano una duplice ambizione: stabilizzare il Medio Oriente aprendo canali di normalizzazione tra Israele e Paesi arabi, e dimostrare che la cooperazione economica e tecnologica potesse convivere con un conflitto mai risolto, quello israelo-palestinese.
Dal punto di vista economico, alcune relazioni hanno retto. Con gli Emirati Arabi Uniti, gli scambi commerciali e i progetti tecnologici non si sono fermati, anzi, hanno dimostrato una certa resilienza. Anche con il Marocco la cooperazione ha tenuto, pur tra tensioni interne. Diverso il caso del Bahrein, dove la pressione dell’opinione pubblica e l’impatto della guerra a Gaza hanno congelato a lungo la partnership.
Ma il punto centrale è un altro: politicamente, gli Accordi hanno perso il loro valore simbolico. Non appaiono più come un processo capace di assorbire tensioni o di fungere da ponte verso una pace più ampia. Al contrario, oggi vengono percepiti da molte opinioni pubbliche arabe come una copertura fragile che permette a Israele di condurre guerre senza alcuna prospettiva di soluzione politica per i palestinesi.
Cosa significa “seppellire” gli Accordi di Abramo
Dire che Netanyahu “seppellisce” gli Accordi non vuol dire che li cancella formalmente. I trattati restano in vigore, le ambasciate non chiudono e gli scambi economici continuano. Ma ciò che muore è lo spirito originario:
- La promessa di stabilizzazione: la normalizzazione doveva ridurre la conflittualità regionale. Oggi vediamo l’opposto: escalation militari, colpi oltre confine, mediazioni sabotate.
- La funzione di ponte: i Paesi firmatari avrebbero dovuto mediare tra Israele e mondo arabo. Ma dopo Gaza, dopo la chiusura di Al Jazeera e ora con l’attacco in Qatar, nessuno di essi può più giocare questo ruolo senza pagare un prezzo interno altissimo.
- L’espansione a cerchi concentrici: l’Arabia Saudita era considerata il “premio finale” degli Accordi. Oggi un accordo con Riad appare lontanissimo: senza una road map politica per i palestinesi, la leadership saudita non può permettersi di legittimare Netanyahu.
In altre parole, gli Accordi non vengono aboliti, ma privati del loro significato politico. Restano gusci economici senza anima diplomatica. È questo il senso del “seppellimento”: non la fine formale, ma l’esaurimento della loro funzione storica.
La scommessa (e i rischi) del “nuovo ordine”
L’approccio di Netanyahu al conflitto e alle relazioni regionali ha garantito a Israele alcuni risultati tangibili e immediati. Da un lato, le operazioni extraterritoriali hanno permesso di disarticolare reti nemiche, colpendo leadership e logistica oltre confine. Questo ha rafforzato l’immagine di uno Stato capace di difendere i propri cittadini senza esitazioni, inviando al tempo stesso un segnale forte a rivali e partner: Israele è pronto a colpire ovunque, senza limiti geografici, se ritiene minacciata la propria sicurezza. Sul piano interno, questa strategia si traduce in un quadro politico in cui il governo può presentarsi come garante della sicurezza e della fermezza, rafforzando il consenso interno in un momento di forte pressione sociale e militare.
Ma se i guadagni tattici appaiono immediati e visibili, i rischi strategici sono altrettanto profondi. Il primo riguarda il rispetto della sovranità e del diritto internazionale: colpire su suolo di Paesi terzi, e per giunta alleati, crea precedenti pericolosi che rischiano di isolare Israele e di fornire argomenti ai suoi detrattori nelle sedi multilaterali. In secondo luogo, questo approccio erode progressivamente gli spazi di mediazione. Senza il Qatar — che finora ha svolto un ruolo cruciale nei negoziati su ostaggi e cessate il fuoco — e con un Egitto sempre più indebolito, il conflitto rischia di scivolare in una spirale senza canali di negoziazione credibili, con costi umanitari e di sicurezza crescenti.
Un terzo rischio riguarda la dimensione regionale. Ogni atto percepito come “punitivo” verso partner arabi rende politicamente sempre più difficile l’ipotesi di un Accordo con l’Arabia Saudita, spostando l’asse della politica regionale da una logica di “pace attraverso investimenti e cooperazione” a una logica di “pace imposta attraverso la coercizione”. Infine, c’è il rischio di divergenze con Washington: sebbene il legame personale con l’attuale amministrazione americana resti solido, mosse unilaterali che ostacolano gli obiettivi statunitensi — mantenere vivi gli Accordi di Abramo e allargarli — rischiano di minare la fiducia strategica e di alimentare frizioni sotterranee.
In sintesi, Netanyahu ha innalzato la soglia di ciò che Israele ritiene di poter fare senza pagare prezzi insostenibili. È una dottrina di pressione che produce vantaggi tattici ma che, nel medio periodo, corrode l’impalcatura politica degli Accordi di Abramo. Se il nuovo ordine regionale si costruisce sul colpire i mediatori piuttosto che sul rafforzarli, allora la normalizzazione non è formalmente morta, ma svuotata del suo senso: non più strumento per assorbire tensioni, bensì fragile cuscinetto su cui rimbalzano urti sempre più violenti. Senza una correzione di rotta — con Washington a fare da regista e partner arabi pronti a sostenere un percorso politico — l’allargamento agli attori chiave come Riad resterà un’ipotesi lontana, e il sistema delle mediazioni non potrà che restare incompiuto, utile solo finché non ostacola la scelta della forza militare.






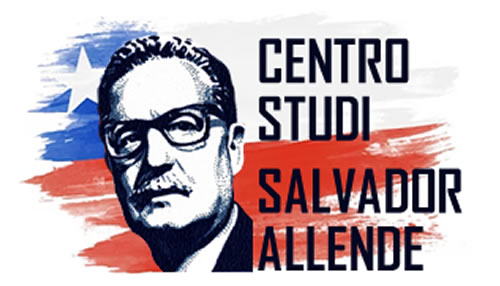






 e poi
e poi