
(Federica Cannas) – Luiz Inácio Lula da Silva ha preso la parola nel plenário principale delle Nazioni Unite a New York, nel corso della Conferenza Internazionale di Alto Livello sulla Palestina, incontro propedeutico all’80ª Assemblea Generale. Un contesto solenne, che ha reso ancora più potente la scelta del presidente brasiliano di parlare del genocidio di Gaza usando esattamente questa parola, quella che molti leader evitano, considerandola troppo radicale o rischiosa.
Una parola che pesa come un macigno e che, pronunciata nel cuore del palazzo di vetro, ha squarciato la cortina della diplomazia rituale per dire la verità. Lula ha scelto di non attenuare la gravità di ciò che accade, restituendo alla politica la forza del linguaggio vero, quello che non si piega alle convenienze geopolitiche e non nasconde dietro formule vaghe l’uccisione quotidiana di migliaia di civili.
Il presidente brasiliano non si è limitato alla denuncia morale. Ha puntato il dito contro il cuore del problema, ossia il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza, usato sistematicamente dagli Stati Uniti per bloccare ogni risoluzione a favore della Palestina. È questo a impedire che l’ONU adempia alla sua missione originaria: proteggere i popoli da nuove atrocità. Un meccanismo nato per garantire stabilità si è trasformato in uno strumento di complicità e ingiustizia, che paralizza l’organizzazione e ne svuota la credibilità.
L’istituzione creata nel 1945 per impedire nuove guerre e atrocità oggi si rivela incapace di fermare un massacro che scuote le coscienze proprio perché ostaggio della volontà di Washington.
Nel suo discorso, Lula ha ricordato che lo Stato di Palestina nacque formalmente dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1947. Eppure, quasi ottant’anni dopo, quel diritto rimane sospeso. La Palestina non dispone di un territorio a causa dell’occupazione illegale israeliana, la sua popolazione è minacciata da un piano di pulizia etnica, e non ha un governo pienamente operativo, perché la comunità internazionale non ha conferito all’Autorità Palestinese i poteri necessari a rappresentare davvero il proprio popolo.
Per Lula, riconoscere la Palestina come Stato sovrano non è più rinviabile, è l’unico modo per restituire dignità e futuro a una nazione che rischia di essere cancellata.
Non è un caso che, nelle stesse giornate di New York, un’onda nuova di governi abbia scelto di rompere gli indugi.
Portogallo, Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato insieme, il 21 settembre 2025, il riconoscimento formale dello Stato palestinese. Francia, Belgio, Lussemburgo e Andorra hanno compiuto lo stesso passo, consolidando una linea europea sempre più netta. La Spagna di Pedro Sánchez aveva già aperto la strada nel maggio 2024, trascinando altri Paesi europei.
Il fronte dei riconoscimenti cresce giorno dopo giorno, isolando chi continua a nascondersi dietro il veto.
Pedro Sánchez, da New York, ha parlato senza giri di parole, affermando che quello che accade a Gaza è il peggior crimine e che non si può fingere di non vederlo. Ha definito l’attuale conferenza ONU un inizio, non la fine del cammino, ribadendo che la Palestina deve essere pienamente riconosciuta e protetta.
Anche leader latinoamericani come Gustavo Petro, presidente della Colombia, hanno ribadito il sostegno alla causa palestinese, intrecciandola alla battaglia per un ordine mondiale più giusto. Dall’America Latina all’Europa mediterranea, il filo rosso è lo stesso: rompere l’inerzia e sfidare il dominio del veto come arma di complicità.
In questo scenario, Lula ha assunto il ruolo di portavoce della sovranità nazionale contro le pretese delle grandi potenze. Lo ha dimostrato nei giorni scorsi con una frase destinata a restare: “Trump è il presidente degli Stati Uniti, non l’imperatore del mondo”. Con queste parole ha voluto chiarire che nessun Paese, per quanto potente, può arrogarsi il diritto di decidere per tutti o imporre il proprio volere come legge universale.
È un messaggio che parla tanto al Sud globale quanto all’Europa. Il Brasile non accetta di essere spettatore in un mondo dominato dai capricci della Casa Bianca. Si propone invece come attore centrale, capace di unire le voci dei popoli che chiedono rispetto e autodeterminazione.
Usare la parola genocidio è un atto di accusa che implica responsabilità precise. Lula lo sa bene e mette la comunità internazionale davanti a uno specchio crudele: il silenzio e l’inazione equivalgono a complicità.
Il presidente brasiliano invita i Paesi a riscoprire il senso collettivo di umanità, quello spirito che nel 1945 aveva unito culture e ideologie diverse con la promessa del mai più. Una promessa tradita troppe volte, dall’America Latina al Medio Oriente, dall’Africa all’Asia. Oggi, davanti a Gaza, Lula chiede che quella promessa venga mantenuta, prima che il termine genocidio diventi un’abitudine e perda la sua forza di scandalo.
La forza del discorso di Lula sta nella sua doppia natura: è al tempo stesso un atto politico e un atto morale. Politico, perché mette in discussione gli equilibri di potere che reggono l’ONU. Morale, perché richiama ciascun Paese a guardare oltre i propri interessi e a misurarsi con l’essenziale: la dignità umana.
Il Brasile, con questo intervento, si propone come voce guida del Sud globale e coscienza critica di un mondo che sembra smarrire i suoi principi. Parlare di genocidio a Gaza, nel cuore delle Nazioni Unite, significa sfidare il silenzio e chiedere coerenza. Se l’ONU non serve a difendere i popoli senza potere, a cosa serve?
Il discorso di Lula resterà come una delle denunce più forti di questi anni, un monito non solo ai governi, ma a tutta l’umanità. Perché il tempo delle parole ambigue è terminato.






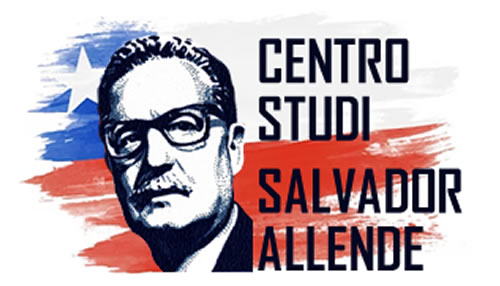






 e poi
e poi