
Il 4 novembre 1995 rimane una data indelebile nella storia di Israele e del Medio Oriente: quel giorno il Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin fu assassinato dopo aver partecipato a una manifestazione per la pace.
Yitzhak Rabin, che aveva servito come Primo Ministro in due periodi (1974-77 e dal 1992), era diventato una figura chiave del processo di pace israelo-palestinese.
Nel 1993 firmò insieme al leader della Organizzazione per la Liberazione della Palestina (PLO) Yasser Arafat e al Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres gli storici Accordi di Oslo, che attribuirono loro il Premio Nobel per la Pace l’anno successivo.
Rabin divenne così un simbolo — pur con tutte le contraddizioni del suo passato militare — della speranza di una coesistenza pacifica e della possibilità di scelte coraggiose in un contesto segnato da conflitti.
La sera del 4 novembre 1995, a Tel Aviv, nel corso di una manifestazione in favore del processo di pace (alla piazza conosciuta fino ad allora come “Kikar Malchei Yisra’el”, che poi sarà intitolata a Rabin stesso), Rabin lasciava il palco e si avviava verso la sua auto.
Uno studente israeliano di destra, Yigal Amir, fortemente contrario agli Accordi di Oslo, lo avvicinò e sparò tre colpi: due raggiunsero Rabin alla schiena, uno ferì lievemente una guardia del corpo.
Rabin fu trasportato d’urgenza in ospedale, ma i colpi risultarono fatali. La sua morte fu annunciata quella stessa sera.
L’assassinio ebbe un impatto profondo in Israele e nel mondo:
- La comunità internazionale espresse solidarietà e condanna: ad esempio, la Nazioni Unite, attraverso la 1ª Commissione dell’Assemblea Generale, definì l’atto come un crimine che minaccia il processo di pace in Medio Oriente.
- L’inchiesta ufficiale, la cosiddetta Commissione Meir Shamgar, evidenziò gravi lacune nei servizi di sicurezza: mancanza di coordinamento, presenza libera dell’assassino vicino all’auto del Primo Ministro, carenze nella protezione.
- Sul piano politico, la scomparsa di Rabin, figura guida del “campo della pace”, segnò una battuta d’arresto per quel percorso: molti analisti attribuiscono all’evento una svolta negativa per le speranze di un accordo duraturo.
A trent’anni dall’uccisione di Yitzhak Rabin, la politica israeliana continua a fare i conti con le domande che il suo assassinio lasciò aperte. L’omicidio del premier da parte di un estremista ebreo mise in luce la fragilità interna della democrazia israeliana e la capacità del conflitto politico di degenerare in violenza anche all’interno di uno Stato che si definisce solido e securizzato.
Rabin rappresentava una leadership atipica: generale divenuto uomo di pace, incarnava la possibilità di trasformare il pragmatismo militare in visione politica. Gli Accordi di Oslo, firmati nel 1993, segnarono un momento di apertura che suscitò speranze e opposizioni in egual misura. Il suo assassinio, due anni dopo, non fermò solo un processo diplomatico, ma interruppe una traiettoria personale che aveva dato un volto umano alla strategia della distensione.
Oggi, mentre il conflitto israelo-palestinese resta impantanato in cicli di violenza e sfiducia, il nome di Rabin torna a indicare ciò che manca più che ciò che resta. La lezione è meno morale che politica: la pace, senza un consenso sociale diffuso e senza una leadership disposta a pagare il prezzo del compromesso, resta un’ipotesi retorica. E la democrazia, quando non riesce a contenere il dissenso entro i suoi confini istituzionali, mostra tutta la sua vulnerabilità.
Nel suo ultimo discorso pubblico, durante la manifestazione per la pace, Yitzhak Rabin affermò di aver sempre creduto che la maggioranza delle persone desiderasse la pace e fosse disposta a correre un rischio per ottenerla. Poche ore dopo, quelle parole divennero il simbolo di una frattura profonda nella società israeliana.
A distanza di trent’anni, quella frase conserva un valore politico più che commemorativo. Riporta al centro la questione irrisolta di quanto consenso reale esista, oggi come allora, attorno all’idea di compromesso. L’assassinio di Rabin segnò la fine di una stagione di possibilità e l’inizio di un lungo periodo di disillusione, ma il principio da lui evocato — che la pace debba essere costruita, non solo auspicata — resta una sfida aperta, sospesa tra pragmatismo e memoria.







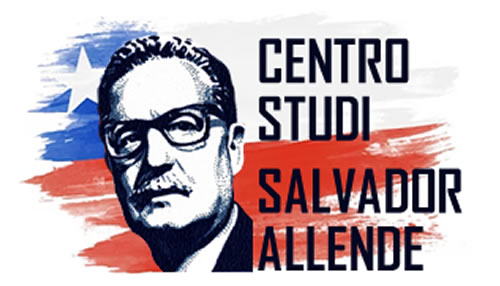






 e poi
e poi