
di Bruno Scapini
Non v’è dubbio. Quale prodromo di un nuovo modo di atteggiarsi del Paese, la vittoria di Donald Trump segna certamente una svolta nella storia degli Stati Uniti d’America.
Abbiamo sentito tante parole correre in queste ore sulle labbra di politologi, giornalisti e osservatori, tutti impegnati a commentare e a spiegare le cause di questa vittoria inaspettata. Tutti, o quasi, in America, come al di qua dell’Atlantico, avevano dato per scontato fino a ieri il successo di Hillary Clinton. Di una Clinton, cioè, che sembrava godere di un unanime appoggio del popolo americano, così come delle lobby e delle elite più potenti dentro e fuori il Paese. Con lei si erano schierati gli esponenti di spicco del mondo finanziario americano, i gruppi del “military-industrial complex” americano, i media e persino l’inimmaginabile mondo di Hollywood con tutte le sue star della “rock music”. Ma evidentemente qualcosa non deve aver funzionato nell’apparato del Partito Democratico o, meglio, deve essere sfuggita di mano ai democratici – e ai loro sostenitori e interpreti – la comprensione del vero senso storico delle elezioni presidenziali. Approfondiamo il punto. Ci aiuterà a capire di più il fenomeno “Trump” e le ragioni di questa sua inattesa ascesa alla Casa Bianca.
Prima di tutto andrebbe osservato come sia del tutto errato e improprio giudicare l’esito delle elezioni presidenziali americane con gli stessi parametri della politica europea. Negli USA, storicamente, i partiti politici non hanno mai avuto il compito di rappresentare e veicolare una ideologia. I Founding Fathers aborrivano le ideologie. E le aborrivano proprio perché le ritenevano causa delle persecuzioni dalle quali invece intendevano rifuggire; e hanno pertanto concepito i partiti, fin dal tempo dei “construction years”, come semplici movimenti sociali, meri strumenti elettorali atti a raccogliere voti per consentire la selezione e la scelta dell’uomo da legittimare presidente. L’epopea americana è piena di esempi di presidenti “trasversali”, di uomini, cioè, che ascesi allo studio “ovale”, hanno, o avrebbero, agito allo stesso modo nelle scelte politiche indipendentemente dalla loro estrazione se democratica o repubblicana. “Trump” si stacca da qualsiasi stereotipo di partito e viene ad assumere agli occhi dell’elettorato americano quel senso di “idea” politica ( non ideologia ) che egli dichiara di impegnarsi a tradurre e convertire in un concreto programma politico. La scelta americana per Trump, dunque, non è stata una preferenza accordata al Partito Repubblicano, né alle sue regole o codici, bensì una preferenza per l’“uomo Trump”, per il buon senso dell’uomo comune, per colui che, semplicemente trascendendo ogni etichettatura politica, non si identifica in nessuna categoria sociale, come in nessuna logica di potere. E proprio per questo viene ritenuto capace di offrire un nuovo ordine all’ interno del Paese come all’ estero, potendo restituire al cittadino medio americano, con il suo pensiero semplice ma diretto, quella normalità di cui oggi probabilmente si incomincia ad avvertire la necessità.
Dichiararsi democratici in America non equivale affatto all’idea di democrazia europea; e sarebbe un grave errore attribuire a un candidato democratico la condivisione di quei valori o principi che in Europa poniamo alla base di una qualunque dottrina democratica.
Su Trump si è detto di tutto e di più. La campagna elettorale tra i due candidati è stata condotta senza esclusione di colpi. Senza risparmiare offese, accuse, calunnie e critiche, giungendo persino alla denigrazione personale biasimandolo per la sua autocrazia e demagogia e, più in particolare, per la inettitudine a garantire la sicurezza del Paese, quale causa certa di una temibile lacerazione della società americana e di una pronosticata perdita della stessa leadership USA nel mondo.
Ma Trump si è invece rivelato come la novità del momento. L’uomo semplice, che avulso dalla retorica del “politically correct” e dai toni enfatici e declamatori di politici ben più navigati si propone quale Presidente di un ritorno alla “normalità”. A quella “normalcy” che di tanto in tanto ricorre nella storia americana allorquando il Paese viene a trovarsi per troppo tempo pressato dalla delusione per un bisogno insoddisfatto di rinnovamento dello stile di vita e dal carico di una responsabilità in politica estera esasperata dagli interventismi militari e dalla demonizzazione degli storici “nemici”.
Trump, per contro, nella sua semplicità espressiva coglie l’essenza delle aspirazioni americane di oggi. Esprime il bisogno di recuperare l’America per gli americani, per prevenire la vera lacerazione della sua società, spettatrice oggi di un mondo in pieno disordine, affetto da instabilità cronica in ogni suo dove e, soprattutto, caduto preda e vittima di incontrollabili bramosie finanziarie senza patria che non riconoscono né ideologie, né governi.
Trump, nella sua “normalità”, incarna, invece, una nuova visione di vita. Una prospettiva più semplice in fondo, atta a ricondurre per mano il temuto “dragon business” di roosveltiana memoria e riconoscendo in politica estera il primato della “partnership” sull’intervento armato ( “saremo giusti con tutti i popoli e nazioni” ha egli dichiarato ). E questo crediamo sia il profilo più significativo del Trump Presidente. Se, infatti, sul piano interno il suo mandato sarà indirizzato a garantire la crescita economica, all’estero indurrà certamente un “re-setting” delle relazioni internazionali; e ciò in direzione non di una loro esasperazione sul filo delle armi, bensì di una loro semplificazione da raggiungersi in primo luogo attraverso una rinnovata intesa con la Russia, interlocutore non solo economicamente necessario, ma strategicamente indispensabile per riportare ordine e stabilità in un mondo oggi in pieno dissesto.
E’questo, in fondo, il “sogno americano”, indefettibile ansia desiderante dell’“american man”, che ciclicamente ripropone sé stesso incarnandosi qua e là in quell’uomo che meglio sa esprimere e rappresentare al momento la speranza di un ritorno alla “normalcy”.












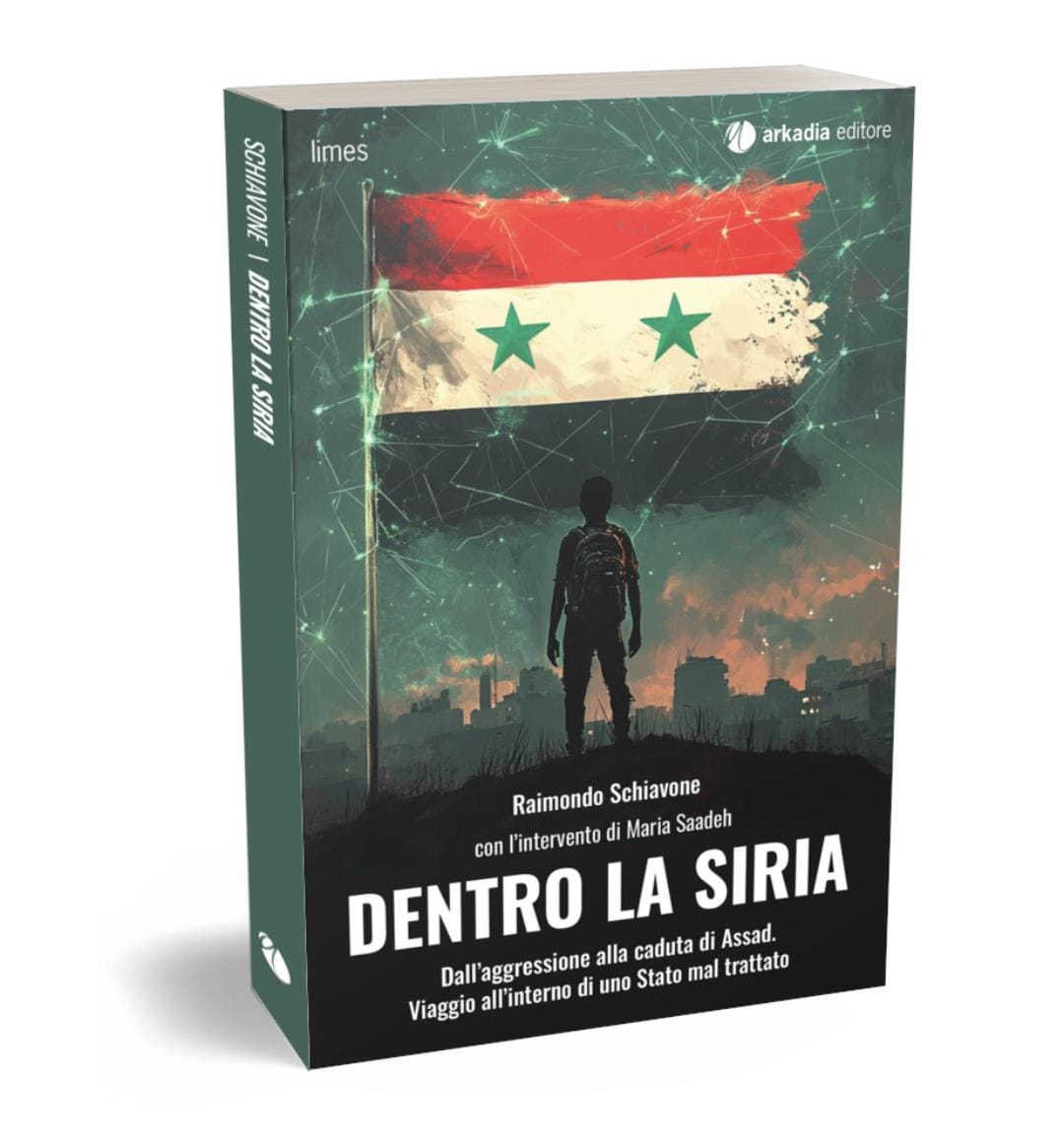
 e poi
e poi