
(Paola Di Lullo – Cisgiordania) – Recarsi da Gerusalemme a Betlemme, Ramallah, Nablus o qualunque altra città della Cisgiordania, Palestina occupata, prevede l’attraversamento di un checkpoint israeliano, dal momento che, dopo la guerra dei 6 giorni del 1967, Israele se l’è annessa, dichiarandola sua capitale. Dichiarazione che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nella risoluzione n.478, ha definito “nulla e priva di validità” , una violazione del diritto internazionale e un serio ostacolo al raggiungimento della pace in Medio Oriente. Ma tant’è, Israele può violare, e ne ha già violate oltre 70, le risoluzioni ONU.
I checkpoint sono parte integrante nel muro, la cui costruzione è cominciata nel 2002 , muro di protezione, secondo Israele, della vergogna, secondo la maggior parte degli osservatori internazionali che hanno avuto il “piacere” di vederlo.
In realtà, il primo progetto di costruzione di un muro riguarda la Striscia di Gaza, dove dal 1987 (prima Intifada) al 1993, Israele ha costruito una barriera elettrificata ermeticamente chiusa.
In Cisgiordania la costruzione è iniziata nella zona ovest di Jenin, ed il suo tracciato è stato più volte modificato, senza che ciò impedisse ad Israele di edificare una mostruosità alta anche 8 metri e lunga, più o meno, 750 km., che ha inglobato vaste aree della Palestina, penetrando profondamente in Cisgiordania, segregando oltre il 20% della popolazione Palestinese, deviando oltre l’80% dei corsi d’acqua. In molti tratti, il muro si discosta dalla linea verde, i confini israeliani entro le linee del 1967, che segue solo per il 20% della sua interezza, anche di circa 30 km, ed ha avuto un impatto devastante sulla popolazione Palestinese : comunità, villaggi, famiglie sono stati e continuano, poiché continua la costruzione del muro, ad essere separati e intrappolati nella loro stessa terra!

Più di 460 checkpoint fissi e mobili isolano villaggi e città palestinesi e bloccano ogni forma di vita economica, paralizzando i sevizi: scuole, ospedali, università, fabbriche e spostamento dei palestinesi e delle merci, bloccando l’economia ed il commercio.
Il Muro che ingloberà tutta Gerusalemme Est, isolandola da Betlemme, è già in fase di costruzione avanzata, mentre Betlemme è stata ridotta a un villaggio. Il Muro arriva alle sue porte, soffocandola, isolandola completamente.
Il checkpoint 300, uno di quelli automatizzati, dove, per fortuna non si incontrano soldati, ci consente di accedere a Betlemme. La prima volta, dal bus, non ci eravamo accorte fosse un checkpoint…solo la presenza dell’esercito israeliano a bordo, che controllava i passaporti degli internazionali, perché ai Palestinesi questo onore non è concesso, loro devono attraversarlo a piedi, ci ha fatto comprendere dove ci trovassimo. Nei giorni successivi siamo scese ad attraversare i vari checkpoint a piedi con i Palestinesi…estranei in casa loro dovrebbero avere un privilegio che loro non hanno? Anzi, che per loro si trasforma in umiliazione inflitta da altri estranei? Perché gli israeliani potranno occupare anche tutta la Palestina, ma sono e saranno sempre estranei e lo sanno, altrimenti non si spiegherebbe tanto uso della forza e delle armi, da parte loro, contro un popolo disarmato, anzi armato, armatissimo di voglia di resistere e vivere in pace e libertà.

A Betlemme visitiamo la Chiesa della Natività, edificata sul luogo in cui ci sarebbe stata la grotta all’interno della quale Maria diede alla luce Gesù. Il luogo è troppo affollato e la basilica in restauro perché mi colpisca come era accaduto, invece, nella Chiesa del Santo Sepolcro. Poi girovaghiamo nel suk, sempre caratteristico, non prima di aver visitato Deheisheh Refugees Camp, uno dei due campi profughi di Betlemme. L’altro è Aida.
Questo campo è stato edificato nel 1949 su una superficie di 500 km. quadrati, ed all’inizio ospitava 400 persone, provenienti per lo più da Khalil e Jerico, in tende edificate dalla C.R.I., che si occupava anche di dare cibo ai profughi che, oggi, son diventati 11.000.
Nel 1953 l’UNRWA cominciò a costruire le prime case, anche a causa degli inverni troppo freddi che rendevano intollerabile la vita nelle tende. Più che di case, si trattava di “scatole di sardine”, come la ha definite la nostra guida, dal momento che la loro superficie era di 3 mt X 3. Con il passare degli anni, su questi primi abbozzi di case, vennero edificati i piani superiori, dal momento che ogni casa può espandersi solo in altezza, a causa della mancanza di spazio dovuta all’alta densità della popolazione del campo.

Oltre alle case, furono costruite le scuole e le strutture pubbliche necessarie, sebbene la tenda, per questi profughi sia rimasta sempre un simbolo. Importante per mantenere lo status di profugo è ottenere una sorta di carta d’identità sulla quale è, appunto, attestato il loro status che, in ogni caso, li rende privi di qualsiasi diritto, tranne quello del diritto al ritorno, sancito dalla risoluzione 194 del 1948 dell’ONU. Ed è per questo unico motivo che i profughi Palestinesi, in Palestina, come in Libano, Siria e Giordania, non intendono rinunciare al loro status, perché non essere più profughi significherebbe perdere anche solo quell’unico diritto riconosciuto loro dall’ONU e dalla comunità internazionale.
Nel campo non c’è acqua corrente, delle autocisterne arrivano due volte al mese e la scaricano in una grande cisterna da cui ogni famiglia ha la possibilità di riempire 7 o 8 contenitori che si possono osservare su tutti i tetti delle case palestinesi, anche fuori dai campi profughi. Come già scritto prima, Israele ha deviato e controlla oltre l’80% dei corsi d’acqua, lasciando ai Palestinesi il restante 20%. Per questo motivo, mentre ogni “persona normale” consuma dai 120 ai 170 litri di acqua al giorno, un israeliano ne consuma circa 369 ed un Palestinese può consumarne solo 18, se nel campo profughi, circa 70 se residente in una città.
In tutto il campo c’è un solo dottore, il che attira l’allarme anche sull’emergenza sanitaria.

Nel 1967 venne costruito il primo impianto elettrico, soprattutto per la necessità di riscaldare le abitazioni. Fino a quel momento, per avere luce e riscaldamento, avevano usato cherosene.
I profughi continuano a rivendicare i loro diritti ad una vita decorosa, al lavoro, soprattutto al ritorno, ma, ci dicono, “in quanto profughi non esistiamo”.
Nel 1967 molti Palestinesi hanno abbandonato i loro campi profughi alla ricerca di una vita migliore in Giordania dove, però, son rimasti profughi ed inoltre, viene loro impedito di rientrare in Palestina.
Viste le continue irruzioni dell’esercito israeliano, irruzioni prevalentemente notturne, perché “il giorno è vostro, la notte è nostra”, alla ricerca di chissà chi, il campo è protetto da molti giovani resistenti che sfidano l’IOF per proteggere gli altri. Sono i tanti, troppi giovani, spesse volte uccisi senza che il mondo ne sia a conoscenza, l’ultimo martire è dello scorso febbraio, perché terroristi che minacciavano il democratico stato d’Israele che fa irruzione nelle loro case sfondando le porte. Perché bussare è da codardi.
* Paola Di Lullo è responsabile dei rapporti con la Palestina della Federazione Assadakah Italia – Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Onlus












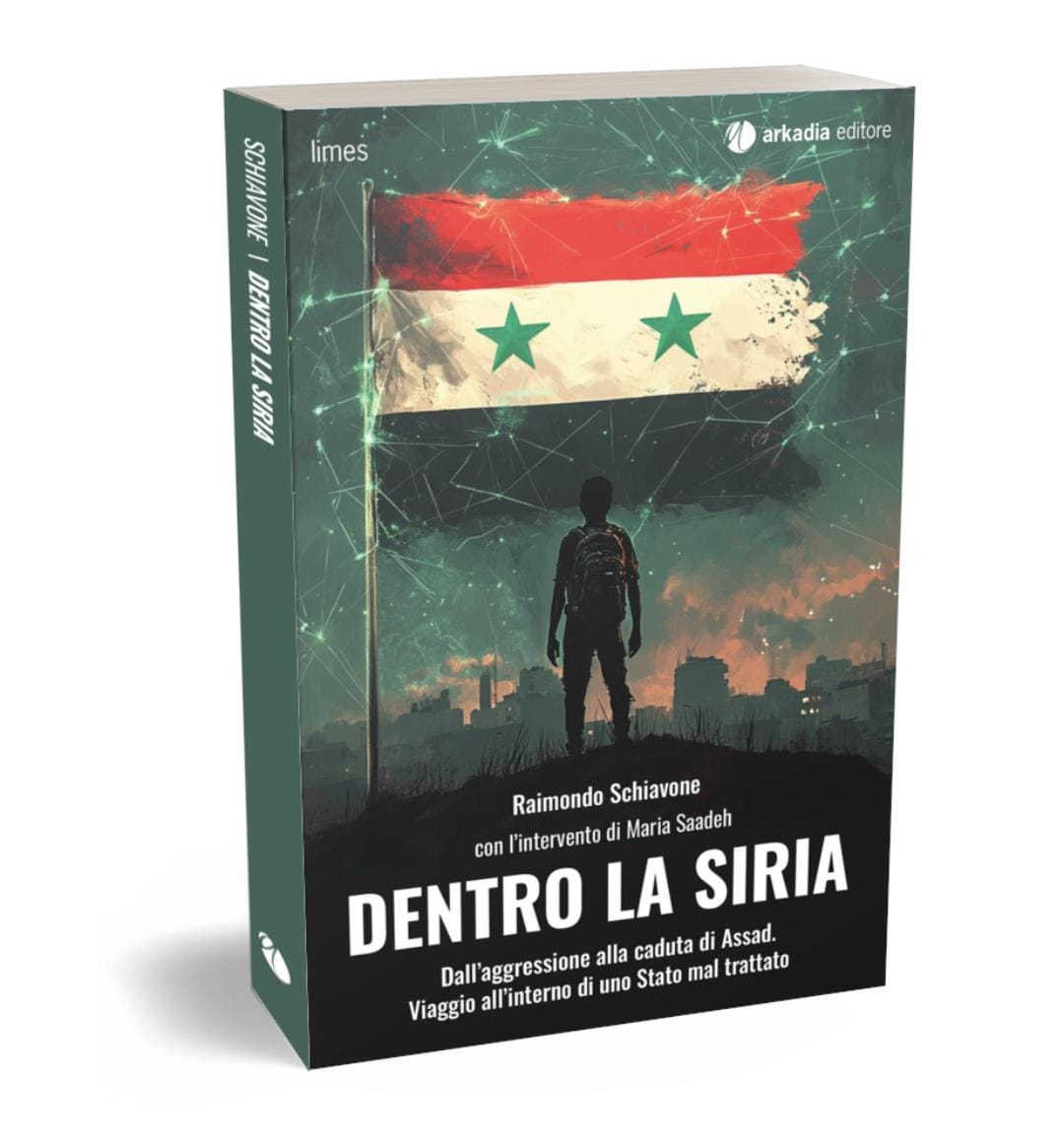
 e poi
e poi