
(Federica Cannas) – Gli Stati Uniti ci hanno abituati a un modo tutto loro di riscrivere la realtà, soprattutto quando si tratta di giustificare le proprie azioni economiche aggressive. Questa volta, nel mirino di Donald Trump non c’è solo il Messico, ma anche il Canada e la Cina, accusati di favorire l’ingresso di migranti illegali e droga negli USA o di non collaborare abbastanza con Washington. Per contrastare queste presunte minacce, il Presidente americano ha deciso di firmare un ordine esecutivo imponendo dazi del 25% su tutte le importazioni messicane e canadesi, e del 10% su quelle cinesi, colpendo così tre dei principali partner commerciali degli Stati Uniti.
Ma c’è un problema. Questa narrazione si scontra con i fatti. Il Messico, sotto la presidenza di Claudia Sheinbaum, sta facendo di tutto per combattere il narcotraffico. Operazioni su vasta scala, arresti di migliaia di criminali, sequestri di droga e armi. Tutto questo racconta una storia ben diversa da quella che Trump vuole far passare. E il governo messicano non ha intenzione di restare in silenzio.
Se Trump pensava di imporre dazi senza conseguenze, sbagliava. Anche il Canada e la Cina hanno reagito duramente alle misure protezionistiche statunitensi.
Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato dazi di ritorsione del 25% su prodotti americani per un valore di 155 miliardi di dollari, colpendo settori chiave come birra, vino, frutta e abbigliamento. Ha, inoltre, sottolineato come queste misure non solo danneggeranno l’economia canadese, ma avranno ripercussioni pesanti anche per gli Stati Uniti stessi. In un’ulteriore mossa simbolica, ha invitato i canadesi a riconsiderare i loro viaggi negli Stati Uniti, sottolineando che le tensioni commerciali potrebbero trasformarsi in un danno per le imprese americane.
La Cina, dal canto suo, ha reagito con fermezza, definendo i dazi “un atto ostile” e annunciando contromisure proporzionate per difendere i propri interessi economici. Pechino ha ribadito che non ci saranno vincitori in una guerra commerciale, esprimendo al contempo la sua disponibilità a negoziare, ma senza farsi imporre diktat da Washington.
In tutto questo, il Messico non è rimasto fermo a guardare. Da quando Claudia Sheinbaum è diventata presidente, la strategia messicana contro il narcotraffico ha subito un cambio di passo deciso. Se il suo predecessore, Andrés Manuel López Obrador, aveva adottato la politica “abbracci, non proiettili”, la nuova amministrazione ha abbandonato questa linea morbida.
Nei soli ultimi quattro mesi, le forze dell’ordine messicane hanno portato avanti un’intensa offensiva contro i cartelli. Oltre 10.000 arresti, sequestro di più di 90 tonnellate di droga, 5.000 armi confiscate. Si tratta di cifre imponenti, che dimostrano la determinazione di Sheinbaum nel combattere il crimine organizzato. A questo si aggiunge l’arresto di esponenti di primo piano dei cartelli, colpendo direttamente il cuore delle organizzazioni criminali.
Eppure, secondo Trump, tutto questo non basta. O meglio, tutto questo non esiste.
Nel giustificare i dazi contro il Messico, l’amministrazione Trump ha dipinto un quadro in cui il governo messicano sarebbe complice del traffico di stupefacenti. Tuttavia, questa versione ignora completamente un aspetto fondamentale: il narcotraffico esiste perché negli Stati Uniti c’è una domanda enorme di droga.
Il Messico è senza dubbio un Paese di transito e produzione per alcune sostanze, ma gli acquirenti sono dall’altra parte del confine. Il fentanil, ad esempio, è un oppioide sintetico che sta devastando gli USA, con migliaia di morti per overdose ogni anno. Ma le sostanze chimiche necessarie per produrlo non vengono dal Messico: arrivano principalmente dalla Cina e vengono sintetizzate negli Stati Uniti. Inoltre, il flusso di droga è strettamente legato al traffico di armi, e qui entra in gioco un altro paradosso. Molte delle armi usate dai cartelli messicani provengono dagli Stati Uniti, dove il mercato delle armi è regolato in modo estremamente permissivo. Secondo dati ufficiali, almeno il 70% delle armi sequestrate ai cartelli ha origine negli USA.
In pratica, gli Stati Uniti si lamentano della violenza in Messico, ma sono proprio loro a fornirgli le armi per alimentarla.
Claudia Sheinbaum ha risposto duramente alle accuse di Trump, rifiutando qualsiasi subordinazione. Ha sottolineato che il Messico non si lascerà dettare condizioni né accetterà di essere il capro espiatorio per problemi che hanno origine negli Stati Uniti.
Inoltre, il governo messicano ha annunciato una serie di misure economiche di risposta ai dazi imposti dagli USA, tra cui possibili contromisure sulle esportazioni americane verso il Messico. Questo significa che la battaglia commerciale potrebbe farsi più aspra, danneggiando entrambe le economie.
Se si guarda alla storia recente, appare evidente che le accuse contro il Messico, il Canada e la Cina siano solo un pretesto. Gli Stati Uniti hanno spesso usato la scusa della sicurezza nazionale per imporre tariffe e proteggere la loro economia.
Quello che Trump sta facendo con il Messico non è molto diverso. Colpire il Paese vicino con dazi significa ridurre la competitività dei suoi prodotti e riportare la produzione negli USA, un tema molto caro alla base elettorale repubblicana.
Ma il rischio è che questa strategia si ritorca contro gli stessi Stati Uniti. Il Messico è il loro primo partner commerciale, e i dazi potrebbero causare un aumento dei prezzi per i consumatori americani, oltre a possibili ritorsioni economiche da parte di Cina e Canada.
La narrativa di Trump è chiara. Gli Stati Uniti sono vittime, il Messico (e ora anche Canada e Cina) sono i colpevoli. Peccato che questa sia una versione distorta della realtà, utile solo per giustificare scelte protezionistiche e alimentare un clima di tensione.
Il Messico, il Canada e la Cina hanno risposto con fermezza, dimostrando che non accetteranno passivamente imposizioni da Washington. Gli Stati Uniti possono continuare a dipingere il Messico come il nemico, ma i dati parlano chiaro. Il traffico di droga e la violenza sono problemi che nascono e si alimentano su entrambe le sponde del confine. E se Washington vuole davvero combatterli, dovrà prima guardare in casa propria.






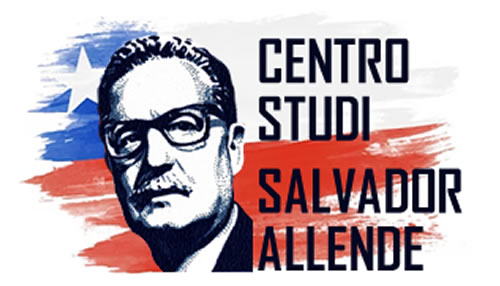






 e poi
e poi